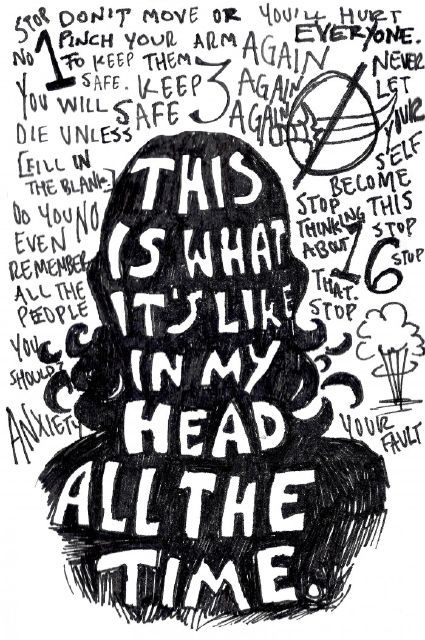Eccomi qui con la seconda mirabolante parte del mio spettacolo a puntate: Alice nel paese della depressione. Nel primo articolo vi avevo parlato di quando, apparentemente all’improvviso, mi sono ritrovata con addosso una bella diagnosi di depressione grave e di come sono stati fondamentali i miei genitori durante questa prima fase. Bene, pensavate di esservi liberati di me? No, vero? Perché oggi vi propongo la continuazione di quella storia e vorrei parlarvi principalmente del secondo, glorioso ed inaspettato, salto ad occhi chiusi senza elastico nella depressione: il primo a 19 anni, il secondo a 26, perché two is megl che one. Ma soprattutto vorrei spiegarvi quanto sia stata fondamentale nel mio caso la terapia, sia psicologica che farmacologica.

Pronti? Ok, vado.
Sia durante il primo periodo di depressione sia durante il secondo ho avuto la fortuna sfacciata di relazionarmi con persone competenti: medici, psicologi, psichiatri, farmacisti, chiunque mi volesse visitare. E qui arriviamo già alla prima questione che solitamente mi fa un tantinello incazzare: la depressione è una malattia, come ho avuto già modo di dire più volte, e come tale va diagnosticata da professionisti ed eventualmente curata con dei farmaci.
Non si può parlare di depressione perché ci si è rotti un’unghia, prima di tutto perché, beh, come dire, è una vaccata e secondariamente perché è giusto un filo irrispettoso per chi malato lo è davvero e con la vostra unghia rotta vi bucherebbe i bulbi oculari.
Quindi, ripetiamo tutti insieme: usare la parola “depressione” a cacchio di cane è sbagliato, amici miei.
Devo dire che con gli anni mi sono un pochino ammorbidita riguardo a questo, sarà l’avvicinarsi a grandi passi dei trenta, chissà. Quando ero una giovincella mi incazzavo di brutto quando sentivo qualcuno usare questa parola a sproposito e non credo ci sia bisogno di sviscerare ulteriormente i motivi. Negli ultimi anni, invece, sto riuscendo ad essere più comprensiva, anche se mi sono rimasti quel prurito alle mani e la bestemmia in gola quando “oooh che brutta giornata, sono depresso”. Non sei depresso, sei solo stronzo.
Va beh, andiamo avanti.
Vi dicevo un po’ più su che, non contenta della prima volta, ci sono ricaduta di nuovo, esattamente dopo aver preso la laurea specialistica (no, giuro, non è colpa della filologia classica!). Sono sempre stata una persona molto metodica, ma proprio al limite del maniacale, quindi per me l’università era una lista di cose da fare e di capitoli da studiare: prima di iniziare a preparare un esame mi facevo sempre una bella tabella ordinata delle pagine che avrei dovuto leggere, schematizzare e ripetere tutti i giorni, con addirittura le ore in cui dovevo mettermi sui libri. Quando finalmente mi sono laureata, mi sono ritrovata di colpo senza questo ordine, senza questi schemi in base ai quali organizzavo le mie giornate e boom, sono andata nel pallone. Nella vita non avevo fatto altro che studiare, avevo lavorato quando ne avevo bisogno, ma non mi ero mai concentrata sul dopo e quando il dopo è arrivato mi ha colta decisamente impreparata. La cosa positiva è stata che ho riconosciuto subito i sintomi e quindi l’ho presa relativamente in tempo, anche se ho dovuto lottare tantissimo per far capire al mio compagno, con cui già vivevo, che porca vacca stavo male davvero, non erano capricci; quando poi l’ha capito anche lui, è stato il mio punto di appoggio più forte.
Quindi – e arrivo finalmente al punto – sia a 19 anni che a 26 mi sono sottoposta a delle cure farmacologiche, oltre che ovviamente ad un percorso di psicoterapia. Ve lo dico sinceramente: all’inizio mica ci volevo andare dalla psicologa e assolutamente non volevo imbottirmi di farmaci, ma la mia forza di volontà era annientata, quindi tutto sommato non ho fatto così tante storie. E meno male, perché quando poi ho realizzato quanto questi professionisti mi stessero aiutando avrei voluto firmare per donare loro i miei organi, anche da viva.
Inizialmente andavo dalla psicologa e stavo zitta, pagavo fior fior di denari per guardare il muro, che cosa meravigliosa. Perché ragazzi, scavarsi dentro è la cosa più difficile che esista. E fa anche male, tantissimo. E fa anche incazzare, detto tra noi, perché vorresti avere tutto subito, vorresti stare meglio dopo due sedute e invece non va affatto così. Però una cosa l’ho capita: uno psicoterapeuta non ha la bacchetta magica, non ti risolve i problemi; quello che fa è dare al paziente gli strumenti per affrontare quei problemi da una prospettiva diversa, con una forma mentis differente, roba che all’inizio pensi “sì dai bella cazzata” e poi invece ti si apre un mondo e ti senti cretina per non averci pensato fino a quel momento.
Poi oh, tuttora quando vado a fare la mia oretta di terapia esco dallo studio piegata in due: è come se entrassi in un frullatore acceso alla massima potenza, tutti i sentimenti e le emozioni si mescolano e vengono a galla e poi affondano di nuovo, ci vuole un pochino per rimettere le cose al loro posto, mica ci si riesce con uno schiocco di dita.
Sento molto spesso dire che gli psicologi sono inutili, che vengono pagati per dirti quello che potrebbe dirti chiunque gratis e in un certo modo forse è anche vero. Non sono dei santoni, non ti infondono il benessere e la salute, però – ve lo assicuro – la mia esperienza parla chiaro: senza di loro non ce l’avrei fatta.
Allo stesso modo, gli psicofarmaci sono fondamentali, nonostante i vari “eeeh ma ti drogano e basta” che sento in giro. Certo, non sono acqua fresca, vanno assunti con cognizione e sotto lo stretto controllo di un medico, ma vi faccio questa domanda: voi vi curereste la polmonite con il the verde? Ecco, no. Perché per guarire da una malattia servono dei farmaci, chiaro e semplice.
Ho preso di tutto, belli miei: antidepressivi, ansiolitici, sonniferi, stabilizzatori dell’umore e chi più ne ha più ne metta. Tuttora sono in fase di décalage (termine usato in psicologia per indicare la diminuzione controllata della dose dei farmaci e che io uso solo per fare la figa) e mi sento tanto Heisenberg quando la mattina devo tagliare a metà la pastiglia che porca miseria parte tipo pallottola vagante. All’inizio gli psicofarmaci ti buttano a terra, mamma mia come ti sfiancano quelle goccine: dolori muscolari, apatia, sonno perenne, libido ai minimi storici, non un bell’effetto insomma. Oltretutto – volete ridere? – tra le controindicazioni della maggior parte degli antidepressivi è segnalata la depressione, ebbene sì, è fantastico.
Poi però, quando l’organismo si abitua e inizia a capire che quei principi attivi in quel momento servono al corpo e alla mente, ci si stabilizza e si va avanti senza problemi e poco alla volta si raggiunge il dosaggio giusto, quello che ci fa essere attivi ma non troppo e ci permette di dormire ma non troppo.
In definitiva, per quella che è la mia esperienza vi dico questo: gli psicofarmaci non funzionano senza un supporto psicoterapico, ma proprio scordatevelo, e in tanti casi la psicoterapia purtroppo non funziona senza la spintarella dei farmaci, questo è quanto.
Esprimo l’ultimo concetto e poi vi assicuro che chiudo, abbiate fede. Ficcatevi benissimo in testa quanto segue: essere seguiti da uno psicologo e/o da uno psichiatra non è una sconfitta. Non è da deboli, non è da mammolette, non è perché avete fallito, giammai.
Semplicemente in quella particolare fase della vita non avete gli strumenti per superare un ostacolo che è enorme e di questo non c’è da vergognarsi. Non siamo matti porco cazzo, ma manco per idea. Ricordatevelo sempre, vi prego.
Bene, direi che ci vediamo al prossimo appuntamento, quando vi parlerò di quello che ho imparato durante i miei anni di depressione, e vi giuro che è più di quanto possa sembrare.